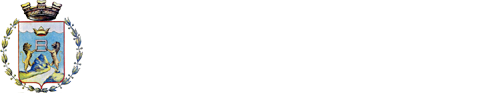STRUMENTI MUSICALI
Gli strumenti che vediamo raccolti raccontano storie diverse e lasciano intravedere i modi differenti in cui la musica è stata praticata nel corso del tempo, ricordandoci quanto la musica e la cultura musicale fossero diffuse non solo ai giorni nostri.
In alto possiamo vedere una fisarmonica di produzione tedesca. È un modello che si diffuse nell'Ottocento, grazie alla sua maggior maneggiabilità e semplicità rispetto agli organetti a mantice che ne sono i “progenitori”.
È una fisarmonica diatonica a bottoni, che si distingue sia dalle fisarmoniche cromatiche, caratterizzate da un maggior numero di tonalità e diversa timbrica, sia dalle fisarmoniche a pianoforte. Le fisarmoniche diatoniche si diffusero attorno alla seconda metà dell’Ottocento: il primo brevetto per una fisarmonica a bottoni venne infatti rilasciato a Vienna nel 1829. La forma che assunsero questi strumenti nell'Ottocento, corrisponde a quella di oggi.
Le fattezze dello strumento, già da alcuni prototipi di epoca Moderna, erano orientate a renderlo facilmente trasportabile. Questa caratteristica diventa centrale con gli esemplari ottocenteschi e novecenteschi e forse anche per questo si lega all’attività dei suonatori ambulanti, data l’adattabilità dello strumento anche a spazi anche di piccole dimensioni.
Lo strumento è entrato nell’immaginario contemporaneo come elemento inevitabilmente legato ad una cultura “popolare”. La fisarmonica richiama immediatamente l'idea della musica popolare, folklorica, delle sagre di paese e della convivialità.
Oggi le sagre sono collegate in maniera ideale e quasi metaforica alle attività pastorali e agricole. Quando questo strumento era in uso, nella prima metà del Novecento, le fiere del bestiame, le feste campestri, come quelle per l'inizio della fioritura, la vendemmia e il raccolto, o ancora i cosiddetti “Maggi”, rappresentavano un momento in cui la festa seguiva o si intervallava a momenti di attività condotti insieme e spesso con l'aiuto di persone provenienti da altri paesi più o meno vicini. Queste feste sono ben documentate durante l'età moderna, ma il loro significato e le modalità di realizzazione cambiano notevolmente tra l'età moderna e l'Ottocento.
Occorre anche ricordare che, nel corso dell'Ottocento, coloro che suonavano in queste feste erano molto spesso suonatori girovaghi che si muovevano tra l’Appennino ligure ed emiliano, e tra i monti e le pianure piemontesi e lombarde. Questi suonatori (che spesso esercitavano anche altre attività) facevano parte di un cospicuo flusso di migrazioni stagionali che coinvolgeva anche pastori transumanti, carbonai, segantini, merciai e venditori ambulanti, muratori. Si trattava spesso di contadini che stagionalmente esercitavano altre attività oppure di artigiani specializzati che, nel corso dell'anno, svolgevano la propria attività in luoghi diversi, passando i confini regionali e nazionali.
Se la pratica della musica ha mantenuto la sua valenza di intrattenimento nelle feste, nelle sale da ballo, con il venir meno delle attività gestione degli spazi esterni agli abitati, essa ha progressivamente perso la sua dimensione più rituale e le connessioni intime con la vita sociale delle comunità e quindi la sua valenza più quotidiana.
Il venir meno del legame tra feste e spazi esterni agli abitati è legato all'abbandono, crescente dopo la metà del Novecento, delle attività agricole e pastorali. Possiamo riflettere su questo anche osservando questa ricca collezione di farfalle, relative a specie comuni in Liguria.
Si tratta di farfalle di provenienza locale, raccolte più di trenta anni fa nei monti circostanti Montebruno dal parroco e da un suo amico quando andavano nei prati per classificare i fiori, in particolare nella zona di Monte Spigo che era il luogo dove si raccoglieva la lavanda (spigo in dialetto vuol dire lavanda). Molte di queste farfalle, tutte ancora molto diffuse in Italia, sono invece ormai scomparse in zona. Sono scomparse perché non ci sono più i prati che erano il loro habitat, ormai abbandonati perché non più sfalciati e pascolati.
Quasi tutte le specie della collezione appartengono infatti a specie che frequentano preferibilmente prati fioriti (o giardini e frutteti). Non mancano alcuni esemplari di specie che si trovano spesso nelle radure o al margine dei boschi. Vedere queste farfalle ci ricorda che se ora intorno troviamo soprattutto boschi cresciuti in seguito all'abbandono, mentre fino a 30-40 anni fa l'area circostante Montebruno era ricca di prati e di aree aperte.
La collezione include da 1 a 4 esemplari di 25 (o 26) specie appartenenti a tre famiglie di Ropaloceri italiani: 1 Papilionide, 6 Pieridi e 18 (o 19) Ninfalidi.
Buona parte delle piante alimentari dei bruchi è rappresentata da specie erbacee (graminacee, crucifere, leguminose, viole, centauree, piantaggini, ortiche). Fanno eccezione il podalirio e la pieride del biancospino, che prediligono le rosacee legnose come il prugnolo, e la cedronella, i cui bruchi si possono trovare sulle foglie di ramni e ligustro.
Sotto di gli strumenti musicali si trova una ricca collezione di statuine del presepe in gesso e cartapesta. Appese alle pareti della sala, proprio davanti agli strumenti musicali, possiamo vedere le immagini che documentano le diverse fasi di allestimento di una carbonaia sperimentale realizzata da Canessa Marco di Montebruno e Luigi Casazza di Conio di Rondanina nel 1999. Sulla produzione del carbone torneremo nella sezione dedicata ai boscaioli.
In fondo alla sala, una collezione di isolatori elettrici in porcellana e interruttori “antichi” provenienti da restauri delle case di Montebruno e dai paesi circostanti.