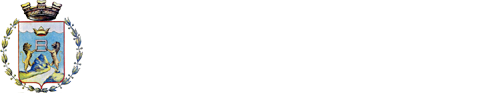LA FIENAGIONE
Gli attrezzi qui esposti sono legati a diversi stadi della fienagione. Vediamo un’ampia collezione di falci, dai lunghi manici, che venivano utilizzate per la gran parte dello sfalcio di prati ed il cui uso è documentato fin dal medioevo, come testimonia ad esempio uno dei mosaici dedicati ai mesi dell’anno conservati nell'abbazia di Bobbio e di poco successivo all’anno Mille. Il lavoro veniva poi rifinito attraverso il taglio con i falcetti, attrezzi più piccoli, trasportabili allacciati alla cintura. Alcuni dei rastrelli servivano invece per raccogliere le foglie cadute dagli alberi durante l'autunno, che poi si riunivano nelle gabbie di paglia e servivano per farne strame e lettiere per le stalle. I rastrelli di legno erano usati soprattutto nella raccolta delle castagne.
La raccolta del fieno aveva generalmente inizio in tarda primavera, non solo per i campi destinati alla fienagione, ma anche per aree i cui usi erano diversificati: vigneti, castagneti, pascoli alberati. Spazi più ampi venivano spesso lasciati per lo sfalcio vero e proprio, che cominciava dopo l’inizio dell’estate (tra Giugno e Luglio) e, a seconda delle vallate e dell'andamento meteorologiche, poteva essere ripetute, generalmente una o due volte, fino a Ottobre.
Era fondamentale che i falciatori portassero con sé martelli e incudini, per affilare e raddrizzare le lame di falcetti e falci durante il lavoro. Le modalità di uso di questi strumenti sono ben descritte dai disegni appesi alle pareti, che permettono anche di conoscere la terminologia locale utilizzata per definirli. Fondamentali erano anche i paradita, che servivano per proteggere le dita dalla lama del falcetto, poiché se la falce incontrava un sasso, la lama poteva “saltare” e colpire le dita del falciatore.
Il fieno era poi disteso sulla superficie sfalciata e lasciato asciugare per alcuni giorni. Forconi e rastrelli permettevano una raccolta più veloce anche per fieno molto folto. Per potere trasportare il fieno, lo si raccoglieva in reti di forma rettangolare costituite da corde legate a due bastoni posti alle estremità, oppure in “gabbie” di paglia o vimini, spesso utilizzate anche nella raccolta di strame e fogliame. Dall'inizio del Novecento il trasporto poteva avvenire anche attraverso sistemi a teleferica, di cui è visibile una riproduzione nella sezione dedicata al “Boscaiolo”.
La raccolta del fieno è stata un’attività fondamentale sulle alture Liguri, che si modificò di pari passo con le attività legate all’allevamento, sia ovi-caprino, sia bovino, e all'alimentazione degli animali da trasporto (come muli e cavalli) coinvolti nelle attività di transito. Anche gli steli del grano che venivano trinciati con appositi strumenti potevano essere usati come fieno per gli animali.
Il fieno, come accennato, poteva essere prodotto sia dallo sfalcio di prati in aree aperte, sia dallo sfalcio dell'erba che cresceva nei castagneti, anche terrazzati, o negli spazi alberati (i pascoli alberati di cui si parla anche nella sezione del boscaiolo). In questi casi lo sfalcio era una delle diverse attività che, con la semina di colture temporanee, il pascolo, il taglio della legna, ecc., venivano realizzate all'interno di cicli che potevano durare diversi anni. Questo avveniva soprattutto nelle terre collettive, le comunaglie, i cui diritti di uso erano goduti da più famiglie o comunità, secondo regole consuetudinarie. Con l'affermarsi dei moderni stati amministrativi a partire dall'Ottocento questi usi e queste modalità di gestione furono ritenute però poco razionali e non sufficientemente produttivi. Gli Stati centrali promossero dei processi di vendita delle terre collettive perché avessero un proprietario e una standardizzazione degli usi in senso monoculturale.
Le terre ad uso collettivo erano entità particolarmente complesse, non facilmente comprensibili secondo categorie prestabilite in quel livello istituzionale. Utilizzi multipli e diversificati di risorse ambientali e degli spazi erano infatti difficili da integrare all’interno del più vasto processo di razionalizzazione degli spazi produttivi, necessario secondo la concezione urbano-centrica delle istituzioni ottocentesche. Il territorio divenne quindi sempre più definito secondo categorie tassative, caratterizzate da attività specifiche, quali bosco, pascolo, aree coltivate, incolti. La storia delle terre collettive di Montebruno, Torriglia e dintorni è ancora da fare, ma può essere interessante notare che contrariamente a quanto succede per Propata, Rondanina, Fontanigorda, a Montebruno e Torriglia non sono praticamente conservate terre collettive.
A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, il pascolo negli spazi alberati fu progressivamente proibito. Nel corso dell'Ottocento, molte norme prevedevano la messa a coltura o il rimboschimento delle aree aperte classificate come “incolti”, e vi furono diverse spinte ad una graduale privatizzazione di terre e boschi comuni o ad utilizzo collettivo. Gli interventi tesi a rendere la montagna più produttiva interessarono anche l'allevamento, con la limitazione delle forme di transumanza a lungo raggio e la spinta verso forme di allevamento stanziale, in cui gli animali andavano “all'alpe” in estate (la cosiddetta monticazione), ma in inverno stazionavano nelle stalle dei paesi. Per questo durante la seconda metà dell'Ottocento la produzione di fieno crebbe considerevolmente, anche in seguito alla realizzazione di prati stabili. La fienagione divenne centrale non solo come attività di sussistenza alla produzione animale locale, ma anche delineandosi come importante attività commerciale che legava versanti e vallate, dato che il fieno ricavato dallo sfalcio era anche raccolto e venduto, ed utilizzato come foraggio per gli animali, in particolare i bovini, che venivano fatti stabulare a valle durante i mesi invernali. Nell’entroterra ligure lo sfalcio veniva fatto sia da membri delle comunità locali, sia, durante l’Ottocento, da braccianti provenienti da altre regioni dell’Italia settentrionale.
Dalla seconda metà del Novecento, con il venir meno anche delle forme di allevamento locale, anche le attività di sfalcio sono progressivamente diminuite. La conseguenza dell'abbandono di queste pratiche è leggibile negli spazi esterni agli abitati, dove nelle aree in passato utilizzate come prati, la mancanza di sfalcio e pascolo ha comportato la sparizione delle specie buone foraggere che erano mantenute da queste pratiche, agevolando la crescita degli arbusti e, in seguito, l’avanzata del bosco che oggi caratterizza i versanti soprastanti i paesi. La conversione delle stalle e dei fienili in abitazioni o magazzini, o il loro crollo, è un'altra traccia di questo processo di abbandono tuttora in corso.