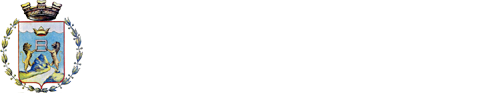LA CANTINA
Qui ci troviamo davanti alla sezione riguardante la cantina. Molti degli oggetti esposti sono strettamente legati alla produzione del vino, tra bigonci, tini e botti. La viticultura è tutt’ora un’attività molto diffusa nei versanti liguri, costieri e dell’entroterra. Nell'Ottocento, il vino era prodotto sia per la vendita, sia per il consumo domestico. Questo, anche se in misura minore, avviene ancora oggi. Gli oggetti esposti permettono di ricostruire il “ciclo del vino”.
Dopo la vendemmia, la pigiatura dell’uva avveniva, sia a mano, sia con bastoni, all’interno di grandi tini, o, per quantità più ridotte, in botti o bigonci. I bigonci sono contenitori generalmente più bassi e larghi delle botti, caratterizzati da due manici ai lati, come vediamo qui sotto. Quello che veniva ricavato dalla schiacciatura veniva poi lasciato nei bigonci a fermentare per alcuni giorni, per poi poter estrarne il mosto, separandolo dalle vinacce. Il mosto, dopo una breve sedimentazione in bigonci o mastelli, diventato limpido, poteva essere travasato nei tini e nelle botti per la successiva fermentazione.
Qui inoltre vediamo un torchio, composto da un corpo centrale di forma cilindrica, due blocchi di legno posti al di sopra e al di sotto di esso e un meccanismo a rotazione su una vite centrale che poteva essere azionato tramite una leva, qui non presente. Nel torchio venivano messe le vinacce dopo la separazione dal mosto, per spremerle e ottenerne un liquido che risultava più torbido del vino e che doveva essere quindi filtrato alcune volte, prima di essere messo a riposo nelle botti. Il vino “torchiato” era spesso tenuto dalle famiglie per uso domestico e non utilizzato per la vendita.
Diverse sono le botti esposte. Grandi contenitori dove il vino veniva lasciato durante il periodo di fermentazione e, successivamente, di riposo. Vediamo, inoltre, una damigiana, contenitore in vetro ricoperto da paglia intrecciata, dove il vino veniva trasferito dopo alcuni mesi di riposo nelle botti, e da cui poteva essere ulteriormente travasato in bottiglie e fiaschi.
La bilancia davanti a noi ci permette di vedere come cambiò la strumentazione relativa alla produzione e alla vendita del vino (e dell’olio d’oliva) nei primi del Novecento. Questo attrezzo permetteva infatti di pesare botti, fissandole entro le due braccia del gancio centrale. Questa bilancia, risalente ai primi decenni del Novecento, proviene dalla fabbrica di pesi, misure e bilance Michele Grasso di Genova, il cui deposito – come indicato sull’oggetto stesso – si trovava in via Sottoripa 133. È un modello particolarmente interessante, perché per forma, leggerezza e trasportabilità richiama le stadere, delle quali un esempio è visibile al primo piano del museo. Le stadere erano bilance utilizzate per pesare merci e oggetti minuti, ampiamente diffuse in contesti domestici e commerciali, ma che difficilmente avrebbero permesso di pesare oggetti di dimensioni più grandi, quali per esempio le botti. Un'altra bilancia, questa volta di precisione come denotano i numerosi pesi, proviene da un negozio di Montebruno e risale alla metà del Novecento.
L'organizzazione di questa sezione rispecchia un altro importante ruolo delle cantine: spazi legati strettamente agli ambienti domestici, dove con il passare degli anni e in seguito ai diversi cambiamenti negli usi e nelle pratiche agricole, produttive e commerciali, si sono depositati e “stratificati” oggetti di diversi contesti e diverse età, non più utilizzati, o utilizzati solo in maniera saltuaria.
Sugli scaffali di questo corridoio troviamo – sotto-forma di oggetti – una miriade di aspetti della vita delle famiglie e delle comunità montane della val Trebbia, perlopiù riferiti al periodo tra Ottocento e prima metà del Novecento, ma con la presenza di materiali anche più antichi, ereditati dalle precedenti generazioni. A destra degli oggetti caratteristici per la produzione vinicola, vediamo una ricca collezione di utensili per la cucina. I catini cosiddetti “maculati”, per via della decorazione a macchie che li caratterizzava, e diverse pentole in ceramica invetriata, sono produzioni prevalentemente Ottocentesche largamente diffuse in Liguria. Si tratta di produzioni quasi mai locali, che offrono una traccia delle reti commerciali in cui Montebruno era inserita. Particolarmente interessanti sono delle pentoline con l'interno giallo, che risalgono agli ultimi decenni dell'Ottocento. Si tratta delle cosiddette “pentoline provenzali”, produzioni savonesi e albisolesi per la cui produzione si usavano argille provenienti dalla Provenza. Allo stesso periodo e dalla stessa area di produzione provengono anche la grande zuppiera e i piatti esposti nella “Cucina”. Si tratta di in questo caso di “terraglie gialle decorate a spugnetta. Produzioni che in quegli anni dal ponente ligure furono vendute in tutta la Liguria e l'Italia centro-settentrionale.
I tanti macinini erano utilizzati per macinare il caffè, l'orzo e fino agli anni Sessanta-Settanta erano un oggetto immancabile nelle case e nelle drogherie. Molti di essi sono databili ai primi decenni del Novecento. Su questo piano vediamo inoltre una collezione di padelle e attrezzi per tostare caffè e orzo (“brestulin”), precedenti alla metà del Novecento. Essi lasciano intravedere la crescente diffusione di questa bevanda, che sempre più entrò nella vita quotidiana delle famiglie durante lo scorso secolo.
Spostandoci ulteriormente, la collezione di taglieri, alcuni molto scavati dall'uso, grattugie per il pane o il formaggio, macchine per lavorare la pasta, tritacarne a manovella, mortai, forni da alloggiare sul runfò delle cucine (l'evoluzione del testo che veniva usato nel camino), ma anche mole, zangole, per la produzione di burro, ci rivela anche le attività che venivano fatte all’interno delle case per produrre gli alimenti consumati dalla famiglia. Vediamo anche altri aspetti della vita famigliare tra questi scaffali: scaldaletto, caratterizzati da una struttura di legno (detta “prete”) che permetteva l’inserimento di uno scaldino in metallo o in terracotta nel mezzo e, posto tra coperte e materasso, di riscaldare il letto ed evitare l’accumulo di umidità che poteva avvenire durante i mesi invernali. Spostandoci verso gli scaffali successivi, ricongiungendoci con le sezioni su semina e fienagione, vediamo molti oggetti legati all’igiene personale, come i catini, ma anche lanterne, alcune delle quali moderne, e una varietà di attrezzi per lavori diversi, per la creazione e la riparazione di attrezzi agricoli o di altri utensili, come i pettinini per i mirtilli, taglieri che presentano ormai profondi solchi legati al prolungato uso.
La ricchezza di materiali che vediamo sottolinea quante attività venivano realizzate all’interno delle famiglie e come la produzione di alimenti e di oggetti per consumo proprio si intersecasse con reti commerciali e di comunicazione di ampio raggio. L'estrema varietà e le varie temporalità degli oggetti che vediamo ci mostra ancora una volta quante attività non vengono più svolte allo stesso modo, o con la stessa intensità, ma ci permette anche di iniziare a comprendere la complessità dei gruppi sociali che hanno utilizzato questi oggetti, attraversando e rielaborando piccoli e grandi cambiamenti all’interno delle proprie vite ed esigenze.