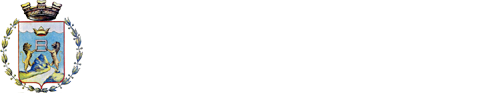IL LAVORO BOSCAIOLO
Gli attrezzi che vediamo qui hanno a che vedere con diversi stadi della gestione del bosco, del taglio e del trasporto della legna e del legname. Ci sono roncole e pennati, attrezzi caratterizzati da una lama ampia ricurva, che erano utilizzati per il taglio di rami attraverso le pratiche dalla potatura e scalvatura. Quest’ultima consisteva nel taglio dei rami laterali degli alberi, che in questo modo venivano fatti crescere dritti, per ottenere, ad esempio pali per le navi. I rami tagliati venivano quindi ripuliti dalle foglie con il pennato. La legna erano usata come legna da ardere, mentre i rami più sottili e le foglie erano usate come foraggio per gli animali sia fresche, sia secche durante l'inverno. Asce e accette servivano per il taglio di rami più imponenti, come nella pratica della capitozzatura, nonché per l’abbattimento dell’albero e la successiva spaccatura della legna in blocchi.
Moltissimi sono i segoni e le seghe esposti, le cui diverse forme e dimensioni sono legate ai loro diversi usi (nonché, anche se è una storia ancora da fare, a differenti cronologie). Le seghe, con telaio rettangolare e la lama posta al centro, erano utilizzate da due persone e servivano per tagliare direttamente dal tronco travi e assi per la falegnameria o la carpenteria (come i travi dei tetti, spesso di castagno). Anche le lunghe seghe con due manici alle estremità erano utilizzate da due persone e servivano per tagliare a pezzi i tronchi, disposti sui cavalletti (detti capre o caprette). Molte poi sono le seghe casalinghe, per tagliare i pezzi di legna da ardere. Anche in questa sezione, i disegni alle pareti aiutano ad approfondire gli usi specifici dei diversi strumenti.
Numerosi sono gli strumenti che rimandano al trasporto della legna. Tra essi, i rampini erano piccoli oggetti molto importanti. Servivano per chiudere le fascine di legna, tenere insieme più oggetti, stringere le corde per legare i tronchi ecc. Sono esposti molti rampini con fogge diverse. Secondo il parroco di Montebruno, le differenze dipendevano non tanto da differenti funzioni quanto dai diversi stili caratteristici di ogni paese, dato che venivano fatti a mano dagli stessi boscaioli e contadini durante l'inverno.
Fondamentali per il trasporto dei tronchi e della legna lungo i versanti erano le slitte, che potevano essere usate per trascinare i tronchi e, se dotate di ceste, per trasportare i pezzi di legna e altri oggetti. Le slitte sono state usate ancora fino agli anni Cinquanta-Sessanta del Novecento. Dopo quel periodo, molti boschi e castagneti in passato utilizzati e gestiti sono stati completamente abbandonati.
Sopra le nostre teste invece è visibile la riproduzione di un altro sistema di trasporto, che si diffuse soprattutto dall'inizio del Novecento: la teleferica, in dialetto “a strafía”. Si trattava di un sistema di trasporto a fune che collegava due stazioni, una a monte e una a valle. Nei sistemi più semplici, il carico (i tronchi, o la legna, le foglie raccolte per farne strame e lettiere, o foraggio, o anche il fieno) attaccato direttamente al gancio o all'interno di un carrello poteva solo scorrere per gravità verso valle. In altri sistemi, sempre dotati almeno di due stazioni, la fune passava su una ruota dentata che, se girata meccanicamente, permetteva lo spostamento del carico sia verso valle, sia verso monte. Le teleferiche hanno permesso (e ancora permettono, dato che molte sono ancora in uso) di trasportare legna e altri prodotti da zone non raggiunte dalle strade. Molto spesso queste teleferiche non erano di un solo proprietario, ma il loro uso poteva essere condiviso, tra più persone. Questo avveniva per esempio all'interno delle cosiddette “comunaglie”, oggi “beni frazionali”, spazi i cui diritti di uso non sono di un singolo individuo o famiglia, ma di una collettività (spesso la frazione) a cui per ragioni storiche è riconosciuto il possesso di quelle terre. I diritti di uso e di accesso a questi spazi e alle loro risorse erano negoziati all’interno delle collettività, attraverso norme e consuetudini non sempre scritti e con un susseguirsi di accordi e conflitti, strettamente legati e reiterati attraverso le stesse pratiche di utilizzo. Questi spazi erano un'entità importante per il sostentamento delle comunità montane di Antico Regime e permettevano di gestire e produrre un’estesa varietà di risorse. La legge italiana le tutela da tempo come beni culturali e dal 2017 riconosce che hanno uno statuto giuridico autonomo: i “demani collettivi”. Storicamente, boschi e selve erano per lo più terre collettive, mentre più frequentemente i castagneti da frutto si trovavano (e si trovano) in terreni privati (spesso terrazzati, tra il Sette e l'Ottocento).
La commercializzazione della legna, in particolare per la carpenteria, la costruzione di centri urbani più estesi, e l’industria navale – in particolare Genovese – è stato un fenomeno di notevole importanza già nel corso del Medioevo e dell’Età Moderna.
Fino all'Ottocento l'aspetto di questi boschi era molto diverso da quello che abbiamo in mente oggi, perché gli alberi erano molto più radi, permettendo così la crescita dell'erba e quindi il pascolo e lo sfalcio. L’Appennino Ligure e più in generale la montagna dalla seconda metà dell'Ottocento furono oggetto di una forte spinta alla commercializzazione del bosco legate alle nuove regolamentazioni promosse dall'amministrazione del regno di Sardegna e poi proseguite dallo Stato italiano formatosi nel 1861. In quel periodo, i grandi alberi, spesso plurisecolari, che caratterizzavano i pascoli alberati furono tagliati per produrre carbone, e gli spazi alberati divennero boschi cedui. All'inizio del Novecento, infatti, la produzione di carbone di legna fu particolarmente incentivata come uno dei mezzi per rendere più produttiva la montagna. La crescita di produzione di carbone, attraverso l’apertura di carbonaie, e della vendita di questo prodotto furono strettamente legate al processo di commercializzazione dei boschi e divennero centrali anche tra le attività economiche della Val Trebbia. Questo avvenne anche sui versanti del Monte Antola, dove le tracce delle carbonaie sono ancora ben riconoscibili nelle faggete cresciute su precedenti pascoli alberati, per la presenza delle antiche piazzole che si presentano come aree pianeggianti (spesso con tracce di terrazzamento) all'interno dei versanti acclivi.
In quel periodo, le figure del taglialegna e del segantino si legano alla crescente rilevanza dell’attività del carbonaio. Professioni che già esistevano, ma che popolarono i boschi appenninici con una nuova intensità. Anche se il pascolo e lo sfalcio non proseguirono nei boschi divenuti ormai troppo fitti, fino agli anni Sessanta-Settanta continuarono le attività di raccolta delle foglie e continuano oggi altre attività di raccolta come i funghi o le bacche, a cui storicamente era legato anche l'uso di molti dei cestini che abbiamo visto al piano di sotto.