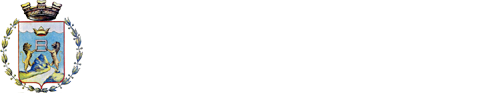LA STALLA
Qui vediamo oggetti e attrezzi legati agli animali da lavoro, il cui ruolo variò e si modificò nel tempo e in relazione a come cambiarono e progressivamente vennero meno molte delle attività agro-silvo-pastorali che avevano caratterizzato la vita di questi versanti appenninici.
Cominciando dalla parete colma di collari e campanacci di diverse misure, e vediamo quali animali erano allevati in queste zone. I campanacci e i collari più grandi erano spesso indossati da mucche e buoi, mentre quelli più minuti da capre e pecore. I collari erano quasi sempre intarsiati dagli stessi contadini e pastori durante l'inverno, con legni come il maggiociondolo o il castagno. Altri collari potevano essere in cuoio e avere forme di cinghie.
I campanacci venivano selezionati in base al suono, perché dovevano permettere al pastore o al contadino di identificare i propri animali durante il pascolo e conoscerne i movimenti nelle aree di alpeggio. I campanelli più piccoli erano per cani.
Mentre gli ovi-caprini erano quasi sempre transumanti e venivano portati a svernare sulla costa, i bovini che d'estate venivano portati nei pascoli comuni, d'inverno venivano stabulati nelle stalle dei paesi. Tra il Sette e l’Ottocento in queste zone, come in altre dell'Appennino ligure, l'allevamento bovino locale crebbe considerevolmente (e con esso la costruzione di stalle e fienili). Quello ovi-caprino invece diminuì, fino a scomparire quasi completamente all'inizio del Novecento con l'interruzione dei circuiti di transumanza a lungo raggio. I bovini erano stati però a lungo anche importanti animali da lavoro, utili per attività quali l’aratura dei campi. Una traccia di questo impiego sono le numerose “pianche”, i ferri pieni che venivano messi ai buoi da lavoro (due per zoccolo). Altri ferri erano per i cavalli oppure, nel caso di quelli più allungati, per muli e asini. Muli, asini e cavalli erano stati l'unico mezzo di trasporto delle merci a lunga distanza fino alla fine dell'Ottocento.
A partire dal Medioevo e fino all’Ottocento, Montebruno insieme ad altri centri come Torriglia costituì un importante centro all'interno della rete di mulattiere che collegavano Genova e gli altri porti liguri con la pianura padana, all’interno di un circuito di scambi fra il Mediterraneo ed il centro Europa. Il trasporto ed il commercio sulla lunga distanza subirono un grande cambiamento con la costruzione di strade carrozzabili dopo la formazione del Regno di Italia e poi con la meccanizzazione alla metà del Novecento. Tuttavia la rete di mulattiere appenniniche rimase fondamentale a livello locale e ancora negli anni Sessanta e Settanta del Novecento il loro uso era tutt'altro che raro. Ce lo testimoniano i numerosi basti per muli che qui vediamo esposti, e gli altri contenitori da trasporto che potevano essere usati per le merci, per il letame e per la sabbia presa al fiume.
La sezione della stalla prosegue con altri utensili legati all'allevamento degli animali: stie per i polli, museruole per i vitellini (per evitare che si attaccassero alla madre che doveva essere munta), mangiatoie e greppie, che erano poste in alto per i cavalli e in basso per i buoi, gerle da mettere sulle spalle per il trasporto di fogliame e fieno che venivano usati nella stalla.
Infine, una parte di questa sezione ospita i finimenti decorativi utilizzati durante le fiere e le feste, dove anche gli animali, il cui contributo era integrante e fondamentale per queste attività, erano presentati e, a volte, veri e propri protagonisti. Qui vediamo infatti collari colorati e decorati, che erano pensati specialmente per feste e fiere dei centri della Val Trebbia. Sebbene queste possano essersi conservate nel tempo, le pratiche agricole, specialmente a partire dagli inizi del Novecento, hanno visto una costante diminuzione della presenza di animali da lavoro. A partire dal dopoguerra, gli animali da allevamento, infatti, sono progressivamente scomparsi dalla vita domestica e dalla quotidianità, per essere relegati sempre più negli allevamenti intensivi. Ancora negli anni Settanta e agli inizi degli anni Ottanta era usuale avere una mucca o qualche pecora, oltre che conigli, galline e maiali, cosa che non è più così frequente. Le tracce del venir meno della coabitazione con gli animali si leggono anche nell'abitato: le stalle e i fienili quando non vengono riutilizzati per altri usi, sono abbandonati, così come ad esempio le porcilaie. Come già accennato, una traccia della scomparsa degli animali domestici è costituita anche dall'avanzata del bosco, che sempre più invade spazi un tempo aperti. Infatti, con il venir meno del pascolo e dello sfalcio legato alla produzione di fieno per gli animali, la crescita degli alberi non è più controllata, con conseguenze negative dal punto di vista della stabilità dei versanti e della pericolosità degli incendi. Negli ultimi anni, in val Trebbia, stanno iniziando esperimenti di ritorno all'allevamento che potrebbero invertire questa tendenza.