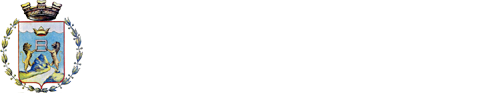LA SEMINA
In questa sezione possiamo vedere gli strumenti legati alle pratiche di coltivazione. Si tratta in particolare di aratri e zappe, strumenti entrambi antichissimi. La scelta tra l'uso dell'uno o dell'altra dipende infatti dalla tipologia e dalla pendenza e dall'ampiezza del terreno da lavorare.
Come noto, le tecniche di aratura e di semina si meccanizzarono a partire dagli anni ’30 e ’40 del XX Secolo, portando, soprattutto nelle aree di pianura, a profonde modifiche nelle pratiche legate alla coltivazione. In montagna e nei versanti terrazzati, date le pendenze e gli spazi più limitati, questi cambiamenti furono meno repentini, perché spesso gli attrezzi a braccia sono ancora oggi preferibili, essendo poco ingombranti e facilmente trasportabili.
Nella sezione possiamo vedere un vomere, un aratro in legno utilizzato per smuovere il terreno e realizzare solchi, spesso trainato da bovini, in particolare buoi.
Grande è poi la varietà delle zappe e delle vanghe, tutte in ferro battuto, appese alle pareti. Queste, una volta fissate su manici in legno, erano utilizzate in diversi stadi della semina e della coltivazione.
Come si vede hanno diverse forme e dimensioni, che dipendono dai diversi usi ai quali erano destinate. Le zappe di forma trapezoidale erano spesso utilizzate per spianare zolle di terra e creare solchi per la semina. Per i terreni più duri erano preferite zappe e zapponi anche molto pesanti, di forma triangolare, dotati di punte che permettessero di smuovere la superficie.
I bidenti e tridenti potevano essere utilizzati per terreni più sassosi, ma anche per smuovere la terra intorno a piantine già cresciute, permettendo una maggiore permeabilità del suolo intorno ad essa.
Occorre anche ricordare che fino a tutto l'Ottocento non erano coltivati solamente i terrazzamenti e i campi vicini agli abitati, ma erano ancora frequenti semine di cereali a cicli brevi (le cosiddette colture temporanee) anche nei versanti più lontani. Questi ultimi erano spesso terre di uso collettivo, le cosiddette “comunaglie”, utilizzate anche per il pascolo e per il taglio e la raccolta della legna, in un'alternanza di usi che, in cicli anche decennali, interessavano gli stessi spazi. In questi spazi l'uso di bidenti e zapponi era fondamentale per preparare il terreno.
Con l'Ottocento, invece, anche a seguito delle riforme promosse prima dal Regno di Sardegna e poi dal Regno di Italia, gli usi degli spazi agricoli, pastorali e forestali si differenziarono sempre di più in senso monoculturale. Per questo, è difficile oggi immaginare che esistessero pascoli alberati o boschi pascolati, in cui la distanza tra gli alberi permetteva anche la crescita dell'erba, che era utilizzata per il pascolo e sfalciata per produrre fieno per l'inverno. Allo stesso modo è difficile per noi pensare che ci fosse un utilizzo controllato del fuoco per limitare la crescita della vegetazione infestante e la propagazione delle plantule degli alberi nelle aree che dovevano rimanere aperte, o che la cenere derivata dalla bruciatura delle potature, venisse sparsa per concimare, o ancora che i fondi coltivati fossero aperti al pascolo vago dopo la raccolta e prima della semina.
In questa sezione troviamo anche una selezione di badili, e, più in là, sugli scaffali, di picconi e pale. I picconi erano anch’essi utilizzati per smuovere il terreno: i più piccoli erano preferiti per la sarchiatura, ovvero per smuovere il terreno attorno alle radici della pianta in crescita, creandovi cunette di terra attorno che ne favorissero la respirazione. I badili che vediamo qui potevano essere utilizzati in diversi momenti relativi alla coltivazione, ad esempio per spostare grandi quantità di terreno, creare canalizzazioni per guidare l’acqua piovana ed evitare che le colture ne venissero sopraffatte, nel caso di piogge molto forti.
Questi attrezzi non servivano solo per l'agricoltura, ma anche per altri usi, tra cui, per esempio la produzione della calce. Quest’ultima si otteneva scavando delle buche, delle fornaci da calce, in cui le pietre di calcare venivano messe a cuocere. Durante la cottura le zappe larghe (come quella a forma di cuore) e i badili venivano utilizzati per mescolare e muovere la massa di calce e poi per spianarla, prima di spegnerla. Spesso, per via delle alte temperature raggiunte al contatto con la calce ancora viva, il ferro si corrodeva parzialmente, lasciando tracce visibili di questo tipo di utilizzo. Le malte di calce con cui sono state costruite e ristrutturate le case fino ai primi decenni del Novecento, così come gli intonaci con cui esse erano rivestite, erano infatti tutti a base di calce prodotta localmente. Non stupisce la diffusione di questo tipo di attività nella zona dell'Antola, che dà il nome ad una formazione geologica che caratterizza un ampio settore della Liguria di Levante e che appunto è denominata “formazione dei Calcari del Monte Antola”.
Questa sezione ospita anche gli attrezzi legati alla trebbiatura e alla ventilazione del grano. Diverse sono le trebbiatrici esposte, il cui funzionamento e la cui cronologia diventano chiare osservando i disegni appesi alle pareti. I disegni aiutano anche a capire come veniva usato il vaglio, che serviva per separare il grano dalla pula.
Questi disegni, come gli altri che possiamo osservare in tutte le sale del museo, furono fatti appositamente per il Museo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta e aiutano a comprendere la nomenclatura, la funzione e il contesto in cui erano usati molti degli oggetti esposti.